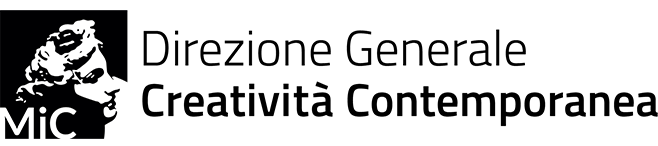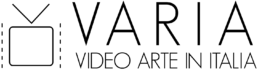Nata come rassegna periodica di arte contemporanea italiana, per iniziativa del Governatorato di Roma, l’Esposizione Nazionale Quadriennale d’Arte di Roma è istituita l’11 maggio 1927. Il compito assegnatole è quello di organizzare ogni quattro anni, a Roma nel Palazzo delle Esposizioni, una grande mostra di arte italiana che presenti al pubblico un panorama delle migliori opere di pittura, scultura e di bianco e nero degli artisti viventi. La creazione della Quadriennale rientrava in un più ampio progetto di riordino nel campo delle arti figurative, voluto dal Fascismo, che pone la rassegna romana in posizione intermedia tra le mostre di carattere locale, organizzate dal Sindacato delle belle arti, e la vetrina internazionale della Biennale di Venezia. La Quadriennale doveva diventare il fulcro del sistema espositivo nazionale, aperta a tutte le tendenze, con opere scelte rigorosamente e con incentivi per gli espositori tramite premi e una consistente campagna acquisti. Per il decollo dell’iniziativa decisiva è la figura di Cipriano Efisio Oppo. Artista, scrittore, deputato al Parlamento del Regno e dirigente del Sindacato artistico, Oppo è il regista delle prime quattro edizioni della Quadriennale nella veste di segretario generale. La partecipazione alle mostre è su invito e su autocandidatura. I protagonisti sono gli artisti, non solo come espositori ma anche come componenti delle giurie per la selezione degli inviti, per l’accettazione delle opere, per l’assegnazione dei premi. Le prime due mostre (’31, ’35) hanno un grande successo di pubblico (oltre 300.000 visitatori per ciascuna edizione) e di vendite (322 opere vendute alla I Quadriennale, 450 alla II) e conducono al consolidamento dell’istituzione che nel ’37 è trasformata in ente autonomo. Caduto il regime e finita la guerra, nel marzo del 1948, alla Galleria Nazionale d’arte Moderna, si apre la V Quadriennale, denominata temporaneamente "Rassegna Nazionale delle Arti Figurative”, proprio per segnare il distacco dalla precedente gestione. Nel 1952, con lo storico e critico d'arte Fortunato Bellonzi come segretario generale, che resterà in carica fino agli inizi degli anni Ottanta, è varata la VI edizione dell’esposizione, non dissimile nell'impianto dalle Quadriennali precedenti, se non per l’introduzione di numerose mostre storiche e retrospettive. Questa impostazione rimarrà salda fino agli anni Sessanta, con edizioni della mostra in cui si raggiungerà il picco del numero degli espositori: nel 1959 alla VIII sono 1200 gli artisti partecipanti. Alle Quadriennali Bellonzi, in collaborazione con il Ministero degli affari Esteri, affianca un’intensa attività di promozione dell'arte contemporanea italiana al di fuori dal confine nazionale. Sotto la sua direzione saranno organizzate un centinaio di mostre, anche itineranti, in Europa, in Asia, in Nord-Africa, in Medio Oriente fino all’America del Sud. Negli anni Settanta si tiene una sola Quadriennale, la X, articolata in cinque diverse mostre allestite tra il 1972 e il 1977. L’impianto classico dell’esposizione muta, si pone termine al sistema dell’autocandidatura, gli artisti possono partecipare solo su invito, e nelle commissioni entrano a far parte i critici d’arte, con un ruolo sempre più preminente. Anche gli anni Ottanta vedranno una sola Quadriennale, l'XI (’86), temporaneamente allestita presso il Palazzo dei Congressi dell'EUR. Negli anni Novanta l’Ente realizza alcune esposizioni storiche di importante rilievo scientifico, come "Secessione romana 1913-1916" (’92), la fondamentale retrospettiva su Enrico Prampolini (’92) e la mostra dedicata a Valori plastici (’99). Sul piano del contemporaneo è organizzata la XII Quadriennale, articolata in due appuntamenti espositivi ("Profili" nel '92 e "Ultime generazioni" nel '96), e la XIII edizione ('99). Nello stesso anno, l'Istituzione da ente pubblico è trasformata in fondazione di diritto civile (D.Lgs n. 419/1999). Nel nuovo statuto del 2001, la Fondazione è denominata "La Quadriennale di Roma". È abolitala la figura del segretario generale, ampliati i poteri del presidente e ribadito il compito di promozione dell’arte contemporanea italiana, sia sul territorio nazionale sia all’estero, anche attraverso l'organizzazione di mostre annuali, l’edizione di pubblicazioni scientifiche e l'attività di ricerca, di documentazione e di catalogazione. Nel 2004, dopo circa settanta anni di residenza nel Palazzo delle Esposizioni di Roma, la Fondazione si trasferisce nel complesso monumentale di Villa Carpegna. Nella nuova sede è inaugurata un’attività continuativa di esposizioni, incontri, presentazioni e l’Archivio Biblioteca viene dotato di una sede dedicata. L'attività espositiva prosegue negli anni Duemila con la XIV Quadriennale, suddivisa in tre mostre tenute a Napoli, Torino e Roma (2003-2005). La XV inaugura nel giugno del 2008 nella sua storica sede del Palazzo delle Esposizioni, da poco riaperto dopo i restauri. A distanza di otto anni, nel 2016, si svolge la XVI Quadriennale, affidata a una pluralità di giovani curatori che focalizzano l'attenzione sulle arti visive in Italia dopo il Duemila. Nel 2017, per la prima volta nella sua storia, la gestione culturale della Fondazione è affidata alla figura di un direttore artistico, Sarah Cosulich, storica e critica d’arte, cui è assegnato l’incarico di delineare e coordinare la programmazione per un triennio, culminante nella Quadriennale del 2020.
Natura giuridica
Mista
Tipologia
Fondazione
Contatti
a.porciani@quadriennalediroma.org
Bibliografia sintentica
Claudia Salaris, «La Quadriennale. Storia della rassegna d’arte italiana dagli anni Trenta a oggi», Marsilio, 2004
«XIV Quadriennale di Roma. Retrospettive 1931/1948», Electa, 2005 (catalogo della mostra tenuta a Roma alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 9 marzo-31 maggio 2005)
Elena Pontiggia, Carlo Fabrizio Carli, 'La Grande Quadriennale. 1935, la nuova arte italiana', «I Quaderni della Quadriennale», n.s. 3, Electa, 2006
Fondi in cui è presente La Quadriennale di Roma
La Quadriennale di Roma (soggetto conservatore)Audiovisivi (serie)